 La letteratura, si dice, è nemica dell’attualità. Si situa in contesti senza tempo, pretende di rappresentare ciò che dura, ciò che non si situa in un contesto determinato. Cerca, forse presuntuosamente, l’universale.
La letteratura, si dice, è nemica dell’attualità. Si situa in contesti senza tempo, pretende di rappresentare ciò che dura, ciò che non si situa in un contesto determinato. Cerca, forse presuntuosamente, l’universale.
La anomala spy story coreana che mandiamo in libreria rompe senza volerlo questo schema. L’impero delle luci del quarantacinquenne Kim Young-ha uscì in Corea del Sud nel 2006. Visitando Seoul nel 2009 mi stupii della scarsa attenzione data a quest’autore, che già aveva nel suo carnet un paio di romanzi interessanti, e da allora ha cominciato a imporsi al mondo: finalista al Man Asian Literary Prize, tradotto e pubblicato in USA, Francia, Germania, e finalmente da noi con questo primo titolo a cui altri seguiranno.
Ma allora, nel 2006, una spy story a cavallo del 38° parallelo sembrava fuori tempo. E invece, forse, Kim Young-ha sapeva prevedere: l’escalation della Corea del Nord, la corsa all’atomica (e ai missili a lunga gittata capaci di portarla lontano), sono procedute a strappi, ma progressivamente. Lo scorso marzo Kim Jong-un arrivava a dichiarare decaduto l’armistizio sul quale da più di sessantanni si incardina la storia di due paesi così diversi, ma costretti a convivere come le due metà di una mela: l’uno, è ormai la rappresentazione museale di un comunismo come non si trova più nel mondo quasi fosse una specie in via d’estinzione, l’altro, è il prototipo di un’Asia emergente e prospera dove le esistenze si avviano verso destini individuali di solitudine e disperazione e deragliamento.
Kim Young-ha racconta la sua storia sul canovaccio dell’ultima giornata da uomo libero di una ex spia nordcoreana a Seoul, un uomo che dopo essersi costruito in vent’anni una famiglia e una carriera si vede improvvisamente richiamato in patria da un ordine inatteso, lanciato da un potere superiore che non dava traccia di sé da più di un decennio. La sua lotta per la sopravvivenza, la reazione all’ordine impartito non sono che l’arena entro il quale Kim Young-ha ci apparecchia lo slowmotion di una mezza dozzina di personaggi sui quali è capace di zoomare con perizia, portandoci avanti e indietro nel tempo lungo trentanni di storia del Nord e del Sud, dove i colpi di scena tipici di ogni grande spy story si rispecchiano nei disvelamenti privati, negli shock connaturati alle esistenze metropolitane di un mondo – quello del Sud – cambiato troppo in fretta.
E qui, va a capire perché, Metropoli d’Asia va curiosamente a incocciare sull’attualità politica e mediatica: mandiamo in libreria L’impero delle luci di Kim Young-ha mentre il dittatore bambino Kim Jong-un sposta i suoi missili da una parte all’altra del paese, tirando la corda senza mai spezzarla, in una sorta di show a beneficio dei propri concittadini che si riverbera sul mondo intero, come ho voluto narrare in un mio editoriale su Doppiozero: Asia a perdita d’occhio.
Tre piccioni con una fava allora: il romanzo e la sua capacità di scavare dentro ai personaggi, la spy story densa di colpi di scena, e, perfino, l’attualità.
Con una ciliegina sulla torta: Kim Young-ha viene in Italia, dopo l’estate. Vogliamo che incontri il nostro pubblico, e sarà il più vasto possibile.


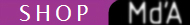


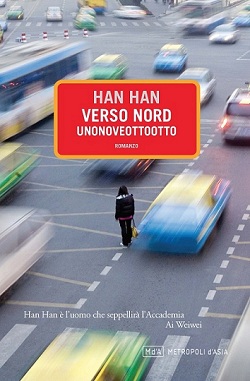
 Quando pubblicammo
Quando pubblicammo  Tra fiuto per gli affari e sfruttamento delle nuove tecnologie, prende piede in
Tra fiuto per gli affari e sfruttamento delle nuove tecnologie, prende piede in 

