 Zhu Wen mi aveva accolto con molti onori. Arrivato a Pechino per la mia prima volta, io ero l’unico editore straniero che avesse deciso di tradurre e pubblicare Dollari la mia Passione (ci fu anche un’edizione francese, ma solo un paio d’anni dopo: Metropoli d’Asia apriva la strada).
Zhu Wen mi aveva accolto con molti onori. Arrivato a Pechino per la mia prima volta, io ero l’unico editore straniero che avesse deciso di tradurre e pubblicare Dollari la mia Passione (ci fu anche un’edizione francese, ma solo un paio d’anni dopo: Metropoli d’Asia apriva la strada).
Per questo poi, negli anni, mi apostroferà come “my boss”, e io mi schernisco rispondendo a mia volta: “my biggest boss”. Quel primo giorno non sapevo che il misto di sussiego e calore con il quale Zhu Wen mi si rivolgeva non aveva niente di formale, niente (per utilizzare l’orrendo termine) di professionale: lui è fatto così.
O almeno: è così che supplisce a un inglese dal vocabolario scarso, che per ottenere una chiacchierata sciolta è costretto a corroborare con gesti e movimenti del capo, o parole singole gettate lì con un sorriso alla “ci siamo capiti, no?”. Cosa che a sua volta lo costringe a metterci più calore ancora: non c’è niente da fare, se una lingua non la maneggi, sei costretto a comunicare per davvero.
Al punto che, noi due dentro alla sua macchina per le strade di Pechino (che nelle sue strade secondarie appare sempre curiosamente vuota e silenziosa: forse perché i mille motorini che ti sorpassano da tutte le parti sono elettrici, quasi clandestini, irreali), lui dentro a una sua giacca di tweed, dopo tre semafori già mi raccontava della scelta di vivere in patria e non all’estero: si era innamorato di un’europea che lavorava qui. E purtroppo, dice, sai, poi è finita. Niente di asettico: mi espone il suo dolore come un fatto, ma un fatto pulsante, carne viva. Tant’è: dopo Tienanmen, quando alcuni tra i suoi più stretti amici se ne andavano in esilio, lui restava. Nella Cina più cupa dei primi anni novanta.
Anni duri (anni da ingegnere elettronico, per la verità, ma niente è più lontano dal giovane che, come mi ha raccontato Ou Ning – ne ho parlato nel post precedente a questo -, passava le nottate a parlar di filosofia e letteratura, in quei primi anni Ottanta che sembravano aperti sul futuro. Quanto meno, dopo decenni di letteratura propaganda, ora nelle librerie arrivavano i russi e gli europei dell’Est, se non gli occidentali: e quanti autori cinesi citano tra i loro maestri Kafka e Dostoevskij).
Ma anni nei quali, piano piano, con l’autocensura consueta agli scrittori cinesi (tutti, anche i dissidenti più noti), scriveva storie profondamente incistate nella società cinese in trasformazione, dense di un dolore collettivo da humour nero che è evidentemente la cifra sua, in grado di farci toccar con mano gli orrendi rapporti interpersonali da opera buffa di un mondo nel quale nessuno davvero più sa dove costruire un noi, e non può accontentarsi di un io autistico, spaurito, e in fin dei conti annoiato.
Intanto, poi, mi portava a spasso dentro a una Pechino autunnale gelida, ventosa, tra i ristoranti e i baretti intorno al lago, ponticelli e alberelli già spogli, e mi ascoltava parlargli dei suoi racconti. Che io, fortunello, avevo trovato recensiti niente meno che su Outlook India, perché I Love Dollars in inglese fu uno tra i primi (e pochissimi, poi chiusero) libri di quella Penguin Asia con sede in Cina (e poi chiusero perché in Cina per gli editori stranieri non è aria). E diceva yes, e io capivo che aspettava di capire se io lo avevo capito, e quando arrivavo al punto diceva yes! You see the ethical tension in it! E pareva sollevato.
Ne era preoccupato: la sua scrittura può esser travisata in cinismo, ma cinica è la Cina, il suo io narrante è invece disperato: e la disperazione, come a teatro, va a braccetto con il riso. Ecco, dovessi definire Zhu Wen mostrerei le due maschere del teatro, la bianca e la nera, la bocca a mezzaluna verso l’alto o verso il basso: cosa che, per altro, accomuna la scrittura di Zhu Wen a tanta arte contemporanea cinese (quella buona e quella “fake”: seriale, perché piace al mercato e ai mercanti d’Occidente): facce ridenti/facce da urlo. Ma sempre stravolte, alterate, quasi dilaniate da forze contrapposte: travolte, in ogni caso.
Fatto sta che incontrandoci di nuovo in Italia, a Venezia, dove Incroci di Civiltà lo aveva invitato a parlare di Dollari appena pubblicato, se ne era parlato, con un gruppo di amici sinologi: perché Dollari, mai considerato da altri, era stato preso da Berrini? E più sommessamente, dopo una serie di commenti negativi al suo terzo film, Thomas Mao che lì avevamo presentato al pubblico, si sottolineava una consonanza tra editore e scrittore in quanto all’editore piaceva persino quel film bislacco e apparentemente senza capo né coda (anche perché composto come dittico, e le due parti sembravano non tenersi l’un l’altra).
Insomma: se ne devo parlare agli amici io sempre ripeto che i libri di Zhu Wen sono da me i più amati di Metropoli d’Asia, e che lo straniamento, l’infelicità grottesca, le vitalità mai doma, l’ilarità sbigottita (ma qui mi par che sto inanellando troppi aggettivi) di quei libri io li riconosco come persona, non come editore.
Ed ecco che Zhu Wen, accantonando il “my boss” definiva la nostra amicizia con un termine cinese che io non riesco né a ricordare né a ricostruire ora (qualcuno mi aiuta?), che identifica due persone che condividono una stessa visione, che sembrano vivere entro uno stesso campo di forze. Come a dire fratellini? E in effetti sono andato a riguardare certe mie prime prove d’autore (pagine e pagine di racconti mai pubblicati, mai letti da esseri umani) venti anni orsono e sì, a ben pensarci la materia che io (nel mio piccolo) e Zhu Wen (uno dei più grandi in Cina) faticosamente decrittiamo è la stessa.
Quando leggo Zhu Wen io mi sento a casa, vedo un mondo dipinto come lo sento (in senso auditivo) io, e vorrei che tutti lo ascoltassero, lo leggessero. L’apparente superfluità della trama nel suo romanzo (Se non è amore vero allora è spazzatura), rispetto alla grana dei personaggi, la circolarità invece dei suoi racconti in Dollari (ben: uno si intitola pure Ruote), una sorta di claustrofobia espressa da una scrittura affastellata, densa, che volutamente si sottrae alle variazioni di tono (monotonica?), tutto concorre. Quasi opere da artista visuale, da performer, più che da semplice narratore.
È la Cina di oggi, questa? La claustrofobia di esistenze senza scampo? In corsa senza saperne un perché? Mandrie imbizzarrite frustate da cowboys senza scrupoli, e stai attento bisonte perché se smetti di correre chi ti sta accanto ti travolge, quindi vai, vai insieme agli altri, e non chiedere mai. E come e perché si adatta a un certo assurdo onnipervasivo che comincia a apparire in codesta Italia insensata, travolta da miriadi di immagini di sé, tutte regolarmente in conflitto tra di loro, da dialoghi al bar in cui non sai mai se chi ti sta di fronte ha ascoltato le tue parole oppure ti risponde come se rispondesse al Tale che ieri a Ballarò ha detto, e poi interviene un’altra che invece ha il problema del biologico: di solito finisce che paghi e torni a casa. Cercando un libro.
PS (sto forse abusando dei Post Scriptum in questi ultimi Post). E Zhu Wen se ne sta, appunto, ben saldo dentro a una sua giacca di tweed, entro una maschera. E quando poi a Pechino mi accoglie, mi dice ti porto in giro io per qualche giorno, è capace di spendere pomeriggi interi con me, parlando poco perché dopo un po’ il suo inglese stenta, ma cercando ugualmente la battuta, e alternando lunghi silenzi come se star seduti insieme un’ora a un caffè senza spicccicar parola sia la quintessenza della comunicazione. E alla fine nel pomeriggio mi porta dal massaggiatore CIECO, tradizione cinese: il massaggiatore usa le mani, il tatto, e se non ci vede meglio così, dice la tradizione.


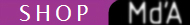





Pingback: chaussure louboutin paris pas cher
Pingback: who sell mcm handbags