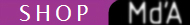Mandira Sen è un’editrice di Calcutta. La sua Stree Samya dichiara di occuparsi di ‘Gender and Social Issues’: le donne innanzitutto, ma anche gli intoccabili, la società indiana e quella del West Bengal, lo stato che ha Kolkata per capitale e che per decenni è stato considerato cuore culturale dell’India e della sua intelllighenzia di sinistra, perché governato da un partito comunista che nazionalizzava e restava legato a doppio filo ai sindacati operai, favorendo ogni forma di espressione artistica: prima di Bollywood il grande cinema indiano è nato qui (Satyajit Rai), e la letteratura in lingua bengalese (che data le sue origini nel 14° secolo) ha vissuto un periodo di rifioritura nei decenni successivi all’indipendenza indiana, sule orme di Rabindranath Tagore. Ci sarebbe da parlarne per pagine e pagine, ora basti dire che i tempi son cambiati, e di parecchio.
Io come sempre preferisco scrivere di lei, di Mandira Sen, di chi le sta intorno, e del nostro incontro. Che mi ha portato in una bella casa della media borghesia di Calcutta, o Kolkata in hindi, o Kolikata in bengali, non ricca ma raffinata, piena di legno e libri, e come sempre di ottima cucina indiana.
Sono a spasso con un gruppo di editori italiani intruppati dall’AIE (di questo sì, dovrò raccontare), spaventati dal disordine, dalla povertà, dal traffico e dalle latrine. Ho cercato di spiegarglielo. Delle grandi città Calcutta è quella che più conserva il segno delle metropoli indiane. Usciamo da un hotel mitologico (il The Grand) che sembra costruito come un fortino, quadrato attorno alle sue palme e alla sua piscina, cesellato di vetri smerigliati e parquet, di lampadari a goccia e marmi (indani? O li portavano da Carrara, da Milos?). Due soldati lo presidiano dentro a una garitta protetta da una lastra di metallo pesante, e puntano i fucili mitragliatori verso l’esterno. Si esce dal cancello ed ecco il giardino delle delizie terrene di Hyeronimus Bosh (e di Indrajit Hazra), i corpi sembrano accatastati l’uno sull’altro, i negozianti siedono a gambe incrociate appollaiati dentro a scatole sopraelevate, i mendicanti implorano, i negozi delle griffe cercano di farsi luce nella confusione. Ma quando le giri a piedi, queste strade, non ti senti minacciato, non temi per le tue saccocce, non hai una sensazione di assalto imminente, semmai un pochino di asfissia. Sono bravi gli editori italiani: sfidano uno schock, e ne escono soddisfatti.
Ma se anche volessi, io pur più avvezzo all’India, chiudermi dentro a un pullmino con aria condizionata, Mandira non me lo consente: nella sua grafia che tanto ricorda quelle dei nostri padri, o nonne, mi da indicazioni su come uscire da una fermata di metrò che prima va, ovviamente raggiunta.
E il metrò è una piacevole sorpresa: niente a che vedere con la modernità esibita di quello di Delhi, men che meno con l’affollamento dei treni urbani di Bombay. Solo, un po’ di coda per il biglietto, davanti a una cassa che sembra uscita dai nostri anni cinquanta: con i foglietti appiccicati con lo scotch per dirti dove devi andare. Vado alla fermata di Kalighat, appunto non lontano dalle gradinate dove si scendeva al fiume un tempo, dedicate a Kali così come il tempietto sotterraneo, incastonato nelle piastrelle a muro della stazione del metrò, baricentro delle indicazioni scritte da Mandira: sali la scala a sinistra dell’altare (però dice shrine: quindi reliquario?) esci e vedrai la mia via.
Il personaggio, in casa, è il marito. Governando i due figli adottati da piccoli, e un cane che vorrebbe sedersi sempre sopra alle mie scarpe, mi racconta del West Bengal. Amit è di una cultura stratosferica, potrei ascoltarlo per ore, anche se non di cultura si occupa: ma di cosa si occupa esattamente? Si descrisse come economista un anno fa, quando ci portò in giro per i vecchi club di Kolkata (Cricket Club, Gymkhana Club, Radio Club, gli stessi nomi che a Bombay, gli stessi arredi coloniali, come a casa loro legni scuri e vetri smerigliati, whisky pregiati, camerieri in livrea). Quando Draghi ha preso il comando della BCE Mandira mi ha scritto: me lo ricordo, era un compagno di studi di Amit, e io ero diventata amica intima di sua moglie: tu per caso non sai come potremmo contattarlo, ora? Figurati. Ma Amit ora mi dice: economista? Beh mi sono interessato di commerci… Il tutto dentro a un salotto di sicuro non leccato, molto poco ‘pettinato’: e il cane puzza, devo dire. Ma qui si beve birra a fiumi, per cominciare.
Protagonisti della serata saranno il mio amico Carlo Laurenti, traduttore di Cioran, collaboratore di lungo corso con l’Adelphi di Calasso, uno stile a metà strada tra l’hippy in ritardo e l’intellettuale British anni ’40, magari omosessuale (ma lui non lo è), magari un po’ fuori, magari ubriaco della sua stessa passione per le connesioni e le reciproche influenze tra Oriente e Occidente, di cui discorre con Sankar, un’amico della famiglia Sen, saggista bengali e traduttore, sempre in bengali, di filosofia classica europea. Mi perdo, scusatemi, non riesco a seguirvi e comunque non dopo questa birra, questo vino, e l’whisky che tengo tra le mani.
E insomma, Mandira? Mandira è la stessa del video che qui in coma ho linkato: qualche improvvisa scivolata verso un sorrisetto insofferente, frequenti riassestamenti su un sorriso solare, dolcissimo, una attempata e giovanissima vecchia signora che doveva essere bellissima anche solo pochi anni fa e che chiunque sposerebbe di corsa ora. Pensieri pieni di whisky, certo.
Bel catalogo, quello di Mandira. Intraducibile in Italia, ma dategli una scorsa: questa è la borghesia intellettuale di Calcutta, che come la nostra non sa più bene dove andare. Uguale uguale, gente. Sono le connessioni: tra l’Oriente e l’Occidente.
Calcutta e Kolkata
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=2010
Local Economy
Li ho incontrati insieme alla Fiera del Libro di Calcutta, davanti al padiglione degli incontri con gli autori naturalmente, e le somiglianze tra i due mi sono saltate all’occhio. Giovani, ruspanti (termine inusuale? A me piace, mi pare designi persone o situazioni o testi o sonorità o immagini che non perdono il contatto con la nuda terra, con la grana dura dell’asfalto. Il suo opposto potrebbe essere: raffinato, letterario, snob, salottiero, evanescente, effimero). Al punto da mettere a dura prova il mio inglese, da loro storpiato gergalmente, e come sempre inframmezzato da termini hindi, masticato dentro alle loro bocche. Di Sarnath Banerjee recentemente ho detto: Sarnath bofonchia. Come una pentola in perenne ebollizione, con un coperchio che le balla sopra e rimanda sbuffi e clangori. Indrajit Hazra no, lui pronuncia le sue frasi con voce stentorea, alza la voce quando occorre, ma il suo vocabolario è un tunnel scavato nella roccia viva, con le pareti graffiate da rostri meccanici, un po’ reminescenze di passate epoche aliene, un po’ modernità barocca.
Hazra ha una rubrica sull’Hindustan Times e lì si occupa di tutto, dal calcio a Bob Dylan, dai senza casta ai politici glamour. Politicamente scorretto quel che basta a regalarci zaffate di verità purissima su un India talmente vasta e complessa da non poter essere ridotta entro alcuno schema precostituito, entro il già detto.
Banerjee è artista visuale riconosciuto, esposto in Europa (anche al Maxxi di Roma), in cerca di una sistemazione semipermanente a Berlino, ben insediato a Londra (mentre Hazra, non so dire perché, in una nostra città ce lo vedo poco), ma indiano fin nel midollo, per nulla anglo-eccetera, a suo agio nella confusione e nella puzza della nativa Calcutta come nel bel mondo dei vernissage di Delhi.
Hazra lo incontri a volte sfranto da buon vino rosso (o cattivo vino rosso indiano). Banerjee ricorda più un nostro artista off da centro sociale, avvezzo ad altri usi e consumi.
Bibliografia: di Hazra il nostro Il Giardino delle Delizie Terrene, ma anche un Bioscope ambientato nella Calcutta dei tempi d’oro del cinema indiano (ruspante), svolto attorno al proiettore 36 o 72 pronto a andare a fuoco appena possibile – come nel Giardino: che finisce con uno dei due protagonisti che da fuoco alla Fiera del Libro di Calcutta (ehi Indrajit, sei qui a dar fuoco al padiglione? Si guarda intorno preoccupato: well, non nominare quel romanzo). Il piromane cominciava la sua carriera lasciando andare a fuoco la casa con la fidanzata dentro…
Di Sarnath Banerjee, graphic novelist, c’è un buon The Corridor (da me inseguito invano perché appariva venduto a un ignoto editore italiano di cui nulla poi si è saputo), storia di un graphic novelist e della sua Delhi (paradossalmente molto milanese, gli dissi una volta), e poi the Barne’s Owl, bellissimo nella scelta di inserire entro al disegno foto vive di Calcutta, che ci appare così in tutto il suo fatiscente splendore, ma poi costruito su una linea narrativa tutta dentro a un passato di battaglie e cavalieri, elmi e spadoni. L’ultimo Harappa Files è una collezione di pezzi brevi o vignette singole: se avete voglia di immergervi nei temi politico sociali trattati quotidianamente dal gossip mediatico indiano, accomodatevi: è perfetto.
In diretta differita, la seguente scena.
Sarnath (Dopo avermi salutato con l’abituale: Andrea, tu sei una spia di qualche servizio segreto, MI5, Mossad. Dove vado nel mondo, Londra, Ferrara, Kolkata, Delhi, arriva Andrea) (E quando dimostro di avere notizie dei suoi spostamenti recenti mi fa: tu mi sembri Lord Shiva, onnisciente e onnipresente): Indrajit tu conosci Andrea?
Andrea: certo, gli ho pubblicato il Giardino.
E Sarnath gli salta addosso: oh, sono entrati un po’ di soldi allora?
Indrajit: beh sai, l’economia italiana è in crisi, Andrea mi ha chiesto una prestazione gratuita.
Sarnath: ah, e l’economia globale va meglio?
Indrajit: recessione.
Sarnath: e l’economia locale? (E mentre Indrajit si gira a parlare con qualcun altro rilancia la domanda: and what about local economy? And what about local economy?).
Sono i nuovi intellettuali indiani. Trenta-quarantenni, circondati da riferimenti globali e occidentalizzati, ma immersi dentro a un humus indiano che è il loro cortile, background perchè backyard (giardino?), questa polvere che non te la stacchi di dosso nemmeno alle mostre dei vari British Institute perché impregnata di delizie terrene a cui non hanno alcuna intenzione di rinunciare. Non sono mica matti.
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1999
Dir di no
Com’è difficile dir di no.
Quando decisi di saltare il fosso, e da scrittore trasformarmi in editore, ero solito dire: son passato dall’altra parte della barricata. La parte comoda, dove tieni il bastone del comando.
Ora, al di là dei molti oneri e dei pochi onori del mestiere di editore (sia esso in partnership con una possente macchina editoriale che ti chiude nel Castello Kafkiano, dove non tu non sai mai chi ha preso la decisione o non decisione sbagliata, e dove ti hanno nascosto il bandolo di una matassa che sempre più ingarbugliano a dovere; o sia esso l’editore indipendente, che a sua volta dipende da uno stuolo di fornitori e collaboratori che giustamente ti tirano per la giacca sette volte al giorno, e il dettaglio di cui ti stai occupando in quei sette minuti è ben lungi dal contenere in sé il mondo ma anzi, moltiplicato per cento costruisce un mosaico rococò di punte degli iceberg, e tu non hai mai il tempo di vederne i sei settimi che stanno sotto), la presunta comodità da Deus ex Machina si infrange davanti al manoscritto di un autore (puoi quasi definirlo un amico) che non ti pare all’altezza.
E allora?
“I am pained”, mi rispose Raj Rao alla mail nella quale gli comunicavo che non avrei pubblicato né preso i diritti da agente di un suo romanzo. Non ne rivelo il titolo, perché Raj sta ancora cercando di piazzarlo, e spero davvero trovi un editore in India. Ma “I am pained”, colpisce me come un cazzotto allo stomaco. Io non voglio addolorare nessuno, non mi piace questa responsabilità.
Mi metto in salvo dunque ricordando i tempi in cui mi trovavo dall’altra parte della barricata. Una volta, dopo un anno di attesa e un lavoro di cesello a fianco di un editor importante, il giudizio finale sui miei racconti fu: “acqua fresca”. L’editor, cercando di consolarmi, disse: che poi non capisco perché acqua fresca vada inteso negativamente.
I racconti furono in seguito accolti (eh già: di accoglienza si tratta, dal punto di vista dello scrittore) da un editore meno importante, e la festa per il loro arrivo nelle librerie fu calorosa e partecipata. Anni dopo un (pessimo, lo ammetto) tentativo di romanzo giallo fu stroncato da un “ci ha molto deluso” (e certo: grazie per le aspettative).
Il giallo comunque fu giudicato troppo allineato a uno stile da serial televisivo, dove invece che sprazzi di realtà si mostrano stereotipi, cliché, luoghi comuni: quanto di peggio, insomma (e inutile stare a raccontare che il mio intento ben altro era da quello: non sono riuscito nel mio intento, quindi zitto e mosca). (NB: una delle due risposte negative mi arrivò un venerdì 13, e qui chi più ne ha più ne metta, perché l’autore rifiutato sa inventarne di ogni).
È invece un venerdì 20, al Jaipur Literary Festival, quando ricevo la chiamata di Raj. Faccio qualche passo nella direzione indicata, mi giro tre volte su me stesso dicendo dove sei, fino a sentir la frase nel cellulare: ti sto guardando.
Raj mi guardava con un espressione torva, perfino spaventata: in ogni caso pained. Ci siamo seduti su due sedie nel prato, circondati da una marea di gente, mentre il suo accompagnatore dopo avermi stretto la mano si accovacciava sull’erba dandomi la schiena. A dirla tutta, Raj quasi non parlava, dovevo tirargli fuori frasi smozzicate.
Capivo che ogni mio atteggiamento rischiava di ferirlo, sentivo la nevrosi nella sua domanda: perché ieri non mi hai chiamato? Avevamo deciso di andare insieme a un party editoriale, ma io ero arrivato tardi a Jaipur e non mi ero fatto sentire. Immaginavo che lui immaginasse che io avessi volutamente evitato di farmi vedere insieme a lui: immaginare è certo prerogativa degli scrittori e degli editori-scrittori, e quindi occhio: a volte bisogna saper mollare la presa.
In ogni caso nei giorni successivi lo ho calorosamente salutato tutte le volte che lo incontravo: mi facevo un punto d’onore di farmi vedere a chiacchierare con lui. Perché la sua, di nevrosi, da scrittore omosessuale e attivista, e accademico che con fatica ha di recente visto riconosciuti i propri diritti in quanto a carriera e posizioni di prestigio, è una nevrosi argomentata, e insomma Raj non ha tutti i torti.
Il suo editor di riferimento in India, colui che aveva gli ha pubblicato i primi tre libri, ha recentemente cambiato posizione. E: “lo sai, l’editoria indiana è piena di donne”. In effetti il suo romanzo ha una donna tra i protagonisti del triangolo amoroso complicato, etero e omo. Troppo luogo comune, troppo cliché. Ma sono d’accordo con Raj: anche la reazione negativa delle pur bravissime donne dell’industria editoriale indiana è improntata a un cliché: le donne che in India faticano a imporre la loro indipendenza, a guadagnarsi il rispetto, rispondono poi a ogni visione critica con un riflesso da politically correct. Cliché contro cliché.
Che dire? L’ho fatto, ho rifiutato il manoscritto. Gli ho anche dato dei consigli, ho capito l’intenzione, ho criticato il risultato. Gli ho augurato di trovare un editore indiano. Gli ho raccontato qualche balla di troppo sul mercato librario italiano. Ho anche provato a girarla dal lato giusto: spiegando per bene cosa intendevo (me lo son riletto due volte nei giorni precedenti all’incontro di Jaipur). Gli ho fatto vedere dove e quando: Raj non era d’accordo, naturalmente.
Ecco che ho fatto, alla fin della fiera: ho scritto questo post, e invece di chiamarlo per nome e cognome, ecco apparire Raj. Raj di qua, Raj di la. Io sono tuo amico. Raj…
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1990
Annie Zaidi, Bombay, 2012
 Annie Zaidi è indefinibile. Leggendo I Miei Luoghi se ne capisce una fragilità testarda, una determinazione che viaggia sul filo della sua ritrosia, una ritrosia che poi d’improvviso scompare in certi gesti quotidiani, l’autorità con la quale, poche sere fa, bypassava una fila di persone per ottenere un mio sandwich al bar del Prithvi Theatre di Juhu, dove stavano presentando, in anteprima assoluta, una sua pièce teatrale: Jaal.
Annie Zaidi è indefinibile. Leggendo I Miei Luoghi se ne capisce una fragilità testarda, una determinazione che viaggia sul filo della sua ritrosia, una ritrosia che poi d’improvviso scompare in certi gesti quotidiani, l’autorità con la quale, poche sere fa, bypassava una fila di persone per ottenere un mio sandwich al bar del Prithvi Theatre di Juhu, dove stavano presentando, in anteprima assoluta, una sua pièce teatrale: Jaal.
Certo, quella sera non poteva che essere al settimo cielo, e poi io le avevo appena messo tra le mani la copia della sua prima edizione all’estero. Ma ancora vedo un’ambivalenza manifestarsi al Festival di Jaipur, pochi giorni dopo: arriva trafelata e in leggerissimo ritardo (1 minuto esatto) a un dibattito di cui avrebbe dovuto essere moderatrice, è desolata, ma non è causa sua: l’organizzazione le ha solo comunicato che avrebbe dovuto introdurre due autori senza fare nomi, le ha dato appuntamento in un posto sbagliato, lei qui nemmeno conosce i due scrittori in questione.
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1977
Han Han nell’occhio del ciclone
 Il suo detrattore definisce Han Han con un epiteto da Rivoluzione Culturale: falso idolo. Basta questo per capire da dove proviene l’ultima campagna di diffamazione nei confronti del giovane scrittore di Shanghai, di cui Metropoli d’Asia ha pubblicato Le tre porte (e altro ancora verrà presto…).
Il suo detrattore definisce Han Han con un epiteto da Rivoluzione Culturale: falso idolo. Basta questo per capire da dove proviene l’ultima campagna di diffamazione nei confronti del giovane scrittore di Shanghai, di cui Metropoli d’Asia ha pubblicato Le tre porte (e altro ancora verrà presto…).
Al di là dell’identità di chi lo attacca (Fang Zhouzi, un blogger famoso per le sue campagne in difesa della proprietà intellettuale, e qui forse in cerca di notorietà), è chiaro che Han Han è sotto attacco.
Le sue posizioni di critica politica e sociale sono una spina nel fianco dell’establishment e gli hanno guadagnato milioni di seguaci (o almeno di followers sul blog), e il modo migliore per cercare di demolire il falso idolo è mettere in dubbio la legittimità del suo ruolo di romanziere: viene così accusato di non essere l’autore dei suoi romanzi che sarebbero stati invece scritti dal padre (sic!) un romanziere e critico poco noto. Come a dire ai giovani cinesi che a migliaia ogni giorno seguono i suoi post: altro che giovane ribelle!
Fatto è che questo attacco viene a ridosso di una serie di critiche piovute sul capo del nostro Han Han proprio da alcuni dissidenti: nei suoi recenti tre saggi, Han Han esprimeva delle posizioni che molti hanno definito troppo moderate.
In sostanza, presentandosi per la prima volta con lo status del leader che negozia col potere, Han Han si diceva disposto a rinunciare alla critica per l’assenza di democrazia formale in Cina (lui ha senpre dichiarato: rispetto la Costituzione, è cioè: non contesto il regime a Partito Unico), pur di vedere garantito per sè e per tutti il diritto di libera espressione.
In sostanza: d’accordo gente, non chiedo la democrazia, ma pretendo di poter dire ciò che mi pare e piace sui vostri misfatti. Anche Ai Weiwei aveva criticato la sua posizione, che a me invece sembra dettata dal realismo (e dalla capacità di essere leader riconosciuto, cosa che purtroppo Ai Weiwei non è, restando confinato nell’empireo delle elite intellettuali) e da una innata vocazione a essere leader di massa (mio dio: termine maoista?).
Adesso arriva l’attacco. Una tenaglia: non lasciamolo solo, lui è uno dei pochi che non se ne andrà in esilio in occidente a farsi applaudire dai nostri media, ma resterà a dare filo da torcere al regime.
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1958
Informazioni, notizie, scrittura, racconto
Capisco quanto questi miei post abbiano a volte un passo che viene travolto da un andamento dello scambio di informazioni che letteralmente mi violenta, mi afferra e mi scaraventa altrove. E non è solo questione di vecchi media.
Recentemente, a Jaipur, intorno al caso Rushdie ho sbattuto il naso su Twitter, che pure MdA utilizza a piene mani, più per scelta “di marketing” che per mio desiderio diretto: insomma, si fa, si twitta, e allora restiamoci dentro anche noi. Quindi: decisione di provare una diretta twitter da Jaipur, con la sensazione di sentirmi esplodere l’hardware tra le mani.
Perché succede questo: che la mia percezione, la mia visione rasoterra del caso Rushdie, che si forma camminando sul prato e lungo i vialetti del Diggi Palace i primi giorni, incontrando scrittori, editori, giornalisti, e si forma assolutamente in diretta, non coincida con la percezione a posteriori, filtrata dalla cassa di risonanza dei media per così dire tradizionali.
Insomma, i primi giorni, dopo l’annuncio della rinuncia alla visita da parte di Rushdie, e perfino dopo l’interruzione (richiesta dagli organizzatori stessi del festival) della lettura di alcuni brani di I versi satanici iniziata per protesta da parte di quattro autori, avevo la netta sensazione che tutti volessero tenere i toni bassi, che sentissero l’argomento come distraente: l’ho già detto, in India i problemi, i fondamentalismi, i poteri, i massacri e le vite perdute sono tali e tante che ogni ‘operatore culturale’ a Jaipur sperava di poter andare oltre Rushdie, e di parlare semmai di quelli, attraverso i romanzi, i saggi, i reportage, le biografie.
La mia ingenuità è stata quella di pensare che Twitter potesse registrare questa sensazione (meglio: questa realtà dei fatti). E quando dico Twitter estendo la definizione a tutto il mondo della comunicazione in rete, quindi Facebook e i blog, anche quelli giornalistici, che vorrebbero rappresentare uno spazio di formazione della notizia diverso (appunto: con un altro passo), e invece secondo me non ci riescono.
È il Festival di Jaipur che è risultato violentato dalla notizia. Invano si è cercato di contestualizzare (ho apprezzato lo sforzo di qualche giornalista indiano di ricordare come un artista dal cognome musulmano, Husseini, sia stato di recente preso di mira dal fondamentalismo opposto, quello dominante in India, cioè quello induista). Gli organizzatori ne sono stati travolti, il loro tentativo di gettare acqua sul fuoco è stato successivamente scambiato per pompieraggio, sabotaggio della protesta.
Perché il caso è montato DOPO, il fatto. La notizia ha preso il sopravvento, è stata ripresa dai media internazionali (che viaggiano con il pilota automatico), ed è letteralmente esplosa nel momento in cui il fatto si stava sgonfiando, e a Jaipur si parlava sì di induismo e islam, o di politica e partiti, o di libertà di espressione, ma argomentando e dialogando, facendo riferimento all’India reale, vera: quella che si vede in modo chiaro tenendo lo sguardo rasoterra, a altezza d’uomo (ecco, a proposito: una volta si diceva: andare a passo d’uomo).
La delusione sta nel vedere come i cosiddetti “nuovi media” si siano adeguati piattamente a questo andamento, divenendo casse di risonanza de La Notizia. Altro che democrazia dell’informazione, pluralità delle voci.
E mentre io mi ritrovo oggi, finalmente, a conversare con partecipazione e interesse insieme a un editore locale e a un esperto indiano di letteratura bengali e a un sinologo italiano con una conoscenza straordinaria delle relazioni tra la cultura asiatica e quella europea, tra persone piacevoli, intelligenti, che mi dicono: è triste come 200 integralisti possano trascinare una nazione intera a parlare di loro. Mentre io ritorno nel mondo reale, qui a Kolkata, alla Fiera del libro, il dibattito sul caso Rushdie comincia a lievitare.
Non c’è niente da fare: se voglio restare col mio passo a raccontare l’Asia che vedo, dal basso, sguardo altezza uomo, bisogna che me ne resti lontano dalle notizie. Dai media vecchi e nuovi.
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1881
Ricapitolando un po’ su Rushdie a Jaipur
 Il giorno prima dell’inizio del Festival alcuni politicanti locali annunciano manifestazioni contro la presenza di Salman Rushdie al Jaipur Literary Festival. Siamo in periodo pre-elettorale e tutto fa gioco: voti musulmani da conquistare. Ricordiamoci che siamo in un paese dove i fondamentamentalismi religiosi (quello indu su tutti) sono vastamente utilizzati come strumenti di consenso elettorale e di potere.
Il giorno prima dell’inizio del Festival alcuni politicanti locali annunciano manifestazioni contro la presenza di Salman Rushdie al Jaipur Literary Festival. Siamo in periodo pre-elettorale e tutto fa gioco: voti musulmani da conquistare. Ricordiamoci che siamo in un paese dove i fondamentamentalismi religiosi (quello indu su tutti) sono vastamente utilizzati come strumenti di consenso elettorale e di potere.
Tutti sono abituati al succedersi di casi del genere. A tratti, con una certa regolarità purtroppo, la conflittualità interreligiosa (che si sovrappone a quella tra Pakistan e India) esplode, nel senso letterale del termine: pogrom, attentati, bombe. Saltano per aria stazioni ferroviarie e altri luoghi frequentati. E questi sì sono fatti importanti.
Ma la notizia delle manifestazioni anti-Rushdie viene trattata dagli organizzatori del Festival e dagli scrittori e intellettuali locali come fatto di routine. Appunto, siamo in un paese che alle notizie minori ci ha fatto il callo.
Il giorno dopo Rushdie annuncia di avere ricevuto dai servizi segreti la notizia che da Bombay sono in partenza due (o tre) killer prezzolati per ucciderlo: e rinuncia al festival. La notizia, di nuovo, è accolta con una certa sufficienza a Jaipur: gli organizzatori chiedono esplicitamente alla stampa di occuparsi degli altri scrittori e non solo del caso Rushdie. La sensazione prevalente è: Rushdie (odiatino e invidiato, uomo di grande potere) si sta facendo un po’ di pubblicità, i politicanti ci rompono come sempre le scatole, il fondamentalismo è la solita tara, ma noi cerchiamo di tirare dritto.
Quattro scrittori invece iniziano una protesta: in apertura delle loro sessioni di dibattito iniziano a leggere brani da I versi satanici. Gli organizzatori accorrono e chiedono loro di sospenderne la lettura. Improvvisamente tutti si rendono conto che il libro è censurato in India (paese a maggioranza induista, non c’è nessuna Sharia, qui). Anzi le autorità locali, saputo dell’accaduto, consigliano ai quattro scrittori di lasciare immediatamente il paese, perché esiste il rischio concreto di essere arrestati (per loro, e il rischio che nel frattempo si spostino consistenti pacchetti di voti).
Di nuovo, la cosa viene accolta come si accoglie la grandine: è l’India, ne succedono di cotte e di crude ma andiamo avanti. Parte una petizione contro la censura a I versi satanici, e qualcuno fa osservare che i libri censurati sono molti, in India: urge un censimento. E le censure appaiono avere carattere di assurdità spesso e volentieri, proprio perché risultato di manipolazioni del consenso da parte di piccoli e grandi potentati politici, a livello nazionale e locale.
Ma quando le autorità centrali (e i servizi) annunciano che non è mai partito nessun allarme riguardo ai killer, e che anzi l’allarme è da considerarsi risibile, a molti cadono le braccia. Rushdie è atteso da un giro di conferenze stampa: c’è un film in produzione tratto da I figli della mezzanotte.
In conclusione: al di là del consueto show mediatico e pre-elettorale, mi pare di vedere tre posizioni differenti.
La prima è quella di autori indiani in voga, vedi il Moccia locale Chetan Bhagat (stranamente tradotto in Italia da un editore bravo e attento come E/O), che rappresentando in modo organico (così si diceva una volta) la cultura del ceto medio indiano, afferma che se Rushdie ha offeso i sentimenti religiosi di qualcuno è giusto che sia perseguito. In sostanza: in India emerge una classe di moderni benpensanti e gli scrittori da show li rappresentano pienamente.
La seconda posizione è quella di autori indiani non residenti, cioè di cittadinanza (e magari nascita) americana o britannica, che reagiscono in modo automatico alla fatwa, senza farsi troppe domande sul contesto: come se il fatto accadesse a Londra.
La terza è quella di molti scrittori e intellettuali indiani (è abbastanza chiaro che io concordo con questi ultimi) che prendono spunto per aprire una campagna sulla censura, ma insistono nel ricordare che in questo paese i problemi sono ben altri (e soprattutto i killer: sui giornali veniva in questi giorni confinata in pagina interna la notizia di quattordici tra poliziotti e cittadini trucidati da un assalto maoista nel nord-est del paese, e sarebbe stato la stessa cosa se si fosse trattato del solito omicidio di massa di contadini da parte delle forze di sicurezza indiane). Salman Rushdie, per queste persone, è proprio l’ultimo dei problemi, in India.
Nota a margine: le prime due posizioni esprimono dei luoghi comuni. La terza è posizione da scrittori veri proprio perché lontana dal luogo comune (o stereotipo che dir si voglia).
Seconda nota a margine: noi occidentali dobbiamo stare molto attenti a non riproporre i nostri luoghi comuni nelle realtà altrui.
E comunque: no alla censura.
PS: In Italia esistono libri e/o spettacoli censurati? Quali? Che sentimenti religiosi offendono?
Foto: kittell
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1866
Annie Zaidi, quattro anni fa, a Delhi
 Il contatto me lo aveva dato Peter Griffin, di Caferati, una fanzine (una volta si diceva così) on line. Lui, non ero riuscito a incontrarlo (abitava a Navi Mumbai, due ore e passa di treno, al di là dello stretto). Andavo a Delhi, e allora mi aveva dirottato su Annie.
Il contatto me lo aveva dato Peter Griffin, di Caferati, una fanzine (una volta si diceva così) on line. Lui, non ero riuscito a incontrarlo (abitava a Navi Mumbai, due ore e passa di treno, al di là dello stretto). Andavo a Delhi, e allora mi aveva dirottato su Annie.
Delhi non era facile da girare, allora. Non c’era ancora il metrò (costruito, alla faccia delle lentezze indiane, a tempo di record), la città è immensa perchè il Raj (l’impero britannico) decise di estendere la piccola Delhi verso sud, e Nuova Delhi (oggi nessuno la chiama così) fu costruita come una serie di lunghi vialoni alberati, interconnessi da gigantesche rotatorie e circondati di verde e di palazzi governativi, o residenze dei potenti, o ambasciate.
Attorno a questa zona di urbanesimo museale nascono poi le cosiddette enclave, e cioè quartieri circondati da un muro, ai quali si accede da cancellate a voste presidiate da guardiani: dentro, si ritrova spesso l’India dei vicoli, e meno spesso un’India di stradine silenziose e edifici bassi, tante piante. Ma taxi, neanche a parlarne, quattro anni fa. Nemmeno un numero per chiamarli, o almeno un numero affidabile. Quindi bisognava viaggiare in autorisciò, nei dieci gradi scarsi delle mattinate di gennaio, a macinare chilometri a decine, aria gelida sulla faccia e fumi di scarico opulenti.
Eccomi dunque a accettare la proposta del mio hotel: una loro macchina a pagamento, prezzi irrisori da India (ma sta cambiando), e, sorpresa, un macchinone grande come una nave e un autista in livrea con tanto di berretto: mai visto in vita mia. E quando penso al mio arrivo sotto la villeta a schiera dove viveva Annie ai tempi provo un senso di vergogna: per i discorsi che ci siamo poi fatti, per i racconti miei di viaggi a piedi dentro alle baraccopoli africane, che incrociavano i racconti suoi di inchieste sul campo, nei villaggi lontani. Parlammo molto di Kapuscinski. Zio Ryszard.
Perché mi presentavo ancora come scrittore, allora: bei tempi, mannaggia. Ero in India a occuparmi d’altro, ma cominciavo a incontrare scrittori più per curiosità che altro. Un’antologia, chissà. Manco sapevo come funzionava davvero, l’editoria. Anche se cominciavo a stupirmi di quanta roba buona leggevo, in inglese, roba di cui nessuno si interessava nel mondo (bei tempi, mannaggia).
Insomma, mi accoglie una giovane ragazza, bellissima e spaventata dal transatlantico con ammiraglio posteggiato sotto casa. Ricordo che, credo per vincere l’imbarazzo, mi offrì un breakfast all’indiana, un ottimo piatto di patate e paratha, pane al burro. C’era una donna, nell’appartamento, intenta a rigovernare, con la quale Annie aveva una relazione evidentemente di complicità. Il donnone mi guardava raggiante, esibendo un sorriso larghissimo che sembrava dire: è arrivato il principe azzurro. Il quale principe si vergognava proprio un bel po’.
E sì che Annie non viene certo dagli slum: una laurea, una madre che le telefona tre volte al giorno (non una parola sul padre, da parte di una scrittrice che della violenza sulle donne fa il perno della propria indagine sul mondo), la bella casa con balcone, una libreria dove trovo Vonnegut (non sarà la prima volta, a Delhi) e altre chicche, tracce esplicite della condivisione con altre due ragazze della sua età (ventisei, ventotto, trenta?), da giovani privilegiate.
Alta middle class, ma con la voglia di guardarsi attorno. Non so bene di cosa ci siamo detti quel giorno, io avrò raccontato i miei monfalconesi, lei i suoi tentativi nella redazione di una rivista per farsi mandare in giro, a fare inchiesta. Griffin me la aveva presentata come giovanissima poetessa, ma qui c’era ben altro: una donna adulta con dei desideri adulti (non sto sminuendo la poesia, sto esaltando la voglia di conoscere, la necessità: la brama, pensa un po’).
Poi sul transatlatico, in mezzo al traffico, a vergognarmi ancora. La portiamo in redazione. A pochi metri dal parcheggio, in coda al semaforo, Annie chiede all’autista di fermarsi, perché una bambina batte sul vetro. Ma non chiede niente. Parlano, in hindi. Annie sembra rassicurarla, le mette una mano sulla testa. Ripartiamo e le chiedo di spiegarmi: dice che conosce la bambina, la vede lì tutti i giorni, per quel che può la fa da chioccia. La bambina le ha detto: ho bisogno di parlarti. Annie ha risposto: arrivo tra dieci minuti.
Dieci minuti: il tempo di salutare questo europeo in transatlantico, e il suo autista in livrea e berretto a visiera rigida (che si è rifiutato di togliersi anche a fronte di una mia precisa richiesta: e, per dirla tutta: allora chi era, quell’uomo silenzioso? Cosa avrà pensato di me? E di Annie?).
Ci siamo rivisti qualche volta, a Bombay e al festival di Jaipur. Lei ha pubblicato Known Turf, con Tranquebar, io lo ho tradotto con I miei Luoghi. Il primo non-fiction di Metropoli d’Asia, forse il libro più bello che abbiamo pubblicato (parola mia: da scrittore).
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1841
Jakarta Trio
 Jakarta non è una bella città, per quel poco che ne ho visto. Vialoni a doppia carreggiata lungo i quali fioriscono i grattacieli, un traffico costantemente bloccato, vie laterali poco interessanti, anche quelle costantemente in costruzione o ricostruzione.
Jakarta non è una bella città, per quel poco che ne ho visto. Vialoni a doppia carreggiata lungo i quali fioriscono i grattacieli, un traffico costantemente bloccato, vie laterali poco interessanti, anche quelle costantemente in costruzione o ricostruzione.
Un centro poco riconoscibile, nessun vero punto di riferimento. Appuntamenti da un lato all’altro della città che costringono a traversate di ore. Blocchi veri e propri, seduto nel taxi fermo che spegne il motore perché così consigliano le autorità. Quando arrivo al luogo dell’appuntamento, il mio interlocutore se ne è già andato, oppure non è ancora arrivato.
La soluzione è: non muoversi, convocare le persone dove sono io, magari nel bar di un grande albergo o di un centro commerciale. Richard Oh ha una soluzione più semplice: fa tappa in un wine bar a partire dal primo pomeriggio, e lì riceve gli ospiti. E, come molti degli abitanti di Jakarta, utilizza ogni mezzo di comunicazione che gli permette di non muoversi: I-Pad I-phone Blackberry, ciascuno con le sue chat, con il suo acceso Skype, e vai di video.
A Richard mi aveva introdotto Sharon Bakar, dama organizzatrice di reading a Kuala Lumpur, vero crocevia per tutto il sudest asiatico. E per il primo incontro Richard mi faceva l’onore di venire a sedersi nella hall del mio albergo: portava con sé due giovani e belle ragazze. Che tra loro, devo dire, si assomigliavano un po’.
Dewi Lestari più alta, entusiasta, letteralmente gasata, un fiume inarrestabile di sorrisi e di parole, e di ottimismo rivendicato come tale, rivenduto a piene mani. E Djenar: Djenar Maesa Ayu, più ombrosa, la bocca piegata a tratti in una smorfia di disgusto, fatica evidente a relazionarsi con me, ci vuole una tenaglia per tirarle fuori qualche parola. Dopo un po’ capisco che, delle due, quella legata a Richard Oh è Djenar. Ma Richard, mi dice, è solo l’agente.
Dewi ha avuto il suo momento di notorietà, nel paese. Supernova è il titolo del volume più venduto di una trilogia new age, racconti incrociati senza una trama evidente, con molti riferimenti alla fisica e alla cosmologia, in cui Dewi sciorina a piene mani il suo verbo: ottimismo, speranza, apertura nei confronti del prossimo, il tutto condito con una passione per il luogo comune che a me non piace.
Vegetariana, buddista solo un po’, prodiga di consigli di vita, abile nel descrivere le situazioni in cui gli abitanti di una grande città si impantanano regolarmente, un romanzo un po’ self-help un po’ avanguardia, del quale basta leggere poche pagine per capire che il tono è quello dello smagliante sorriso di Dewi Lestari, della sua fiducia incondizionata nella vita e nel prossimo.
Agente di sé stessa, sì: capisco che per quanto riguarda Dewi la posizione di Richard Oh è invertita, rispetto al suo ruolo di agente di Djenar: l’ha portata da me perchè introdurla a un editore europeo è buon modo di guadagnare la sua fiducia, di portarsela in scuderia (si dice così, con gli agenti: siano poi purosangue di pedegree, giovani puledre, o semplici stalloni da traino, gli scrittori vengono messi in pista, testa bassa, briglie sciolte e frustino in piena attività; chi vince?).
Dewi la incontrerò di nuovo all’Ubud Literary Festival sulla magnificente isola di Bali, sorprendentemente su un palco con un microfono in mano: ha iniziato come cantante, il suo miglior lavoro, mi dirà, è un cd musicale, che si vende con una raccolta di racconti in allegato: Rectoverso. In sostanza: una artista vera (è una bellissima donna, ma non è questa la ragione del suo successo, in Indonesia sono tutte così), ma una scrittrice (e un essere umano) troppo di maniera. Simpatica, però.
(Una piccola digressione: io quando incontro donne così, molto comprese nella loro parte di credenti new age, piene della loro fiducia e quindi fede nel futuro, e di un ottimismo cosmico, non riesco a non pensare a certe nostre donnette di chiesa, alle suore, alle signore di parrocchia raggianti per l’ultimo atto di beneficienza. Certo asessuate queste: e Dewi non lo è di certo. Però…).
Quanto Dewi appare un po’ già vista, clone locale di un cliché americano, tanto Djenar è sorprendente. Innanzitutto l’età: pensavo sotto i trenta, ma Djenar Maesa Ayu è già nonna. Poi il legame con Richard Oh: un giorno che vuole incontrarmi le chiedo di venire nel solito centro commerciale dove ho appuntamento con Richard, lei mi chiede di non farglielo sapere, e mi riceve in un angolo lontano di un bar ai piani superiori: mi dice: abbiamo rotto, preferisco non incontrarlo. Faccia scura, sguardo contrito.
Prima, e dopo, questo nostro incontro io la vedo sempre insieme a Richard, a Jakarta e a Ubud, dove loro due sembrano ospiti fissi. Di Djenar Maesa Ayu leggo una raccolta di racconti tradotta in inglese: They Say I am a Monkey. Una via di mezzo tra l’allegoria e la fantasia morbosa, o malata. Spesso il punto di vista è quello di una bambina alle prese con i molti visitatori che sua madre riceve in casa, o con un’ adulto che le porta un grosso serpente, o con il dolore fisico provocato da ripetute cadute di cui non riesce a capacitarsi, e delle quali una coppia di genitori le impone di non raccontare niente a nessuno.
Il suo romanzo invece è Nayla, in cui l’io narrante è una ragazzina alle prese con una madre paranoica, che le serra la vagina con una spilla da balla, come un’infibulazione punk. La ragazzina cresce, e i suoi passi verso l’età adulta sono scanditi dalle esperienze sessuali in serie, che la emancipano dal ricordo del dolore fisico subito. E qualcuno dice: Nayla è autobiografico. E qualcun altro dice: lo dice lei, che Nayla è autobiografico: ci ricama sopra, la ragazza, sulla propria presunta autobiografia di sofferenza.
Eppure Djenar ha avuto davvero una figlia in giovanissima età (sedici anni), e la sua smorfia tradisce un disagio non di facciata. Si relaziona spesso con me in modo nevrotico, prima mi da appuntamento di nascosto da Richard, poi mi incontra a Ubud con Richard e mi dice che loro abitano insieme, poi di nuovo a Jakarta mi dirà che Richard non è più il suo agente, e che lei vuole trattare direttamente con me.
Il bianco e il nero, Dewi e Djenar. L’ottimismo e il pessimismo, la gioia e il dolore (e io perchè preferisco la scrittura della seconda? Perché mi pare un terreno più solido su cui poggiare i piedi, perché mi pare che la verità di Djenar, anche se falsificata, racconti più della fantasia esorbitante di Dewi).
In mezzo, tra le due, serafico e tondeggiante come un piccolo Budda (e da noi si direbbe: ci sta come un Papa), Richard Oh imperversa. Nel suo wine bar mi offre una cenetta da leccarsi i baffi, vino buono di Francia. Oh è cognome cinese, quella indonesiana è una delle comunità più perseguitate dell’Asia del sudest: Richard ne ha raccontato in un paio di romanzi (molto poco riusciti, mi dicono) e autopubblicati. Lui di mestiere, sostiene, mette in contatto le persone. Giornalista, organizza un Katulistiwa Literary Award ogni anno: libri buoni, libri meno buoni (MdA ha partecipato a una edizione, e non abbiamo pubblicato il romanzo vincitore e da noi premiato!).
Foto: fidzonflickr
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1829
I temi, appunto: di che scrivono gli asiatici?
Appunto: è una parola che ricorre nei miei post. Un invito a rimarcare ciò che già ho scritto, quindi a ritornarci sopra, scrivendo come fosse punto a croce, con l’ago che torna a raccogliere il nodo già serrato e lo riaggancia più avanti, un passo oltre.
Provo a interpretarmi: quel che sto facendo è riprendere, dall’Asia, un percorso già iniziato (riannodo fili, è chiaro). Da qui raccolgo suggestioni, temi, frammenti di un mondo che descrivo e commento per quel che è: un mondo altro e distante (nuovo? parola oggi orrenda). Ma tra le righe ci leggo un riverbero della realtà mia, nostra: e allora lego e confronto, per procedere ancora (e non lo faccio solo scrivendo, ma anche scegliendo un romanzo da tradurre e pubblicare più che un altro).
E in quel che vedo non trovo un Altro a noi opposto (dove noi siamo Ricchi l’Asia è Povera, dove noi siamo Materialisti, loro sono Lo Spirito, dove noi siamo in Recessione, loro sono in Crescita), ma al contrario: ritrovo gli stessi interrogativi nostri, i nostri temi riproposti. Ma quali, dunque? Proviamo.
Gli scrittori e il mondo che hanno attorno. Il loro, di mondo. Le motivazioni, le ragioni dello scrivere. Che stanno dentro a esperienze individuali, ma anche dentro a una precisa connotazione sociale: i narratori asiatici non sono miliardari né senza casta né contadini espropriati né operai ridislocati. Sono professionisti, tutta gente che non vive al piano terra o nei seminterrati, ma su in alto, appartamenti con vista. Chirurghi, avvocati, scriptwriter, giornalisti, accademici, pubblicitari, videomakers. O figli e figlie: di manager, industriali, avvocati e chirurghi ancora.
Una certa aria nostra da secondo dopoguerra: dove da noi era ricostruzione e boom economico, qui è costruzione tout-court, e boom economico. Con tutto quel che si porta dietro: trasformazioni sociali, contrapposizioni e intersezioni tra ceti sociali diversi. Tra la ricchezza e la povertà: un baratro. Chiedendosi sempre, lo scrittore che sta in lassù, cosa succede in basso, e la società in generale, i media e i cosiddetti opinion leader, cosa sia giusto o sbagliato fare.
Consumi, ceto medio (ocio però: qui si dice middle class e si intende davvero chi sta in mezzo. Da noi si usa ceto medio per descrivere quasi tutto). Irreggimentazione dei comportamenti, frustrazione conseguente. Noia, forse, e al contrario una sottile sensazione di panico incombente (bellissima, ‘sta cosa, come ho già detto: Ballardiana).
Le donne: un ruolo nuovo, affrancate non tanto dai fornelli quanto piuttosto scaraventate in una modernità fatta di corsi di basket e nuoto per i figli, e di eterna rincorsa allo status. Da un lato, donne capaci di mettere in discussione la norma, l’abitudine consolidata, e di spingere in avanti il mondo. Dall’altro, donne come primo veicolo di consumismo, informazione come gossip, dittatura dell’emozione sul raziocinio.
Relazioni tra gli individui: estraneità e cattiveria, una buona dose di disperazione, ricerca a tutti costi di un pezzo di piacere, e a tutti costi vuol dire che lo si paga caro. Balle a gogò su sex and drugs and rock and roll, qualche verità omosessuale. Un bel tocco di solitudine.
E i lettori: narcisismo e paura del mondo. Qui i bestseller sono i cosiddetti self-help books, che ti insegnano a difenderti dal capo, a non essere timido, a utilizzare a pieno regime le tue risorse intellettuali e fisiche, a coltivare l’aggressività e la leadership! E poi tutti i romanzi che parlano del noi: noi quando eravamo all’università, noi giovani ribelli, noi famiglia in ascesa. Un io plurale ipertrofico, fin sgargiante.
https://www.metropolidasia.it/blog/?p=1826