 L’ultimo weekend del Singapore Writers Festival ha visto finalmente la presenza di qualche ospite di prestigio dall’Asia.
L’ultimo weekend del Singapore Writers Festival ha visto finalmente la presenza di qualche ospite di prestigio dall’Asia.
Il paradosso è stato però la discussione con Murong Xuecun e Xi Er sulle problematiche della traduzione dal cinese nelle lingua occidentali. Molti ne hanno parlato, a margine del festival, delusi dal fatto che la sessione fosse in cinese senza… traduzione.
In questo paese dalle molte lingue l’argomento potrebbe generare utile dibattito, anche perché qui si sta cominciando a fare esperienza di un ritorno al cinese, dopo decenni in cui l’inglese si è imposto come lingua franca e del sistema scolastico.
I ragazzi, abituati fino a pochissimi anni fa a parlare cinese tra di loro e in famiglia ma a leggere in inglese, ora trovano una produzione letteraria (e cinematografica) in cinese. Questo porta alla ribalta anche una narrativa singaporeana in cinese che in passato restava nell’ombra. Insomma, tra Chinese e English speakers, bisognerà che cominciamo a parlarci davvero. Qui e nel mondo intero.
Tra gli autori presentati, Bi Feyu si è trovato di fronte a un uditorio sorprendentemente striminzito. Bi Feyu è autore di due romanzi che in inglese sono stati tradotti con Moon Opera e Three Sisters. È un esponente di quella schiera di scrittori cinesi più famosi all’estero che in patria, perché capaci di andare a incontrare il gusto dei lettori occidentali narrando di cambiamenti a cavallo delle varie epoche storiche (la conquista del potere da parte dei comunisti, la Grande rivoluzione culturale, gli Anni ’80 delle speranze di cambiamento frustrate dalla repressione di Piazza Tien an Men, il boom economico recente delle metropoli).
Abbiamo già citato un’intervista di Jo Lusby, prestigiosa editor di Penguin a Pechino, che elencava questi elementi del gusto occidentale che a suo parere gli scrittori cinesi possono andare a incontrare con successo. Ma a Singapore casca l’asino: Bi Feyu interessa meno un popolo di lettori di origine cinese che non è disposto a mediazioni di quel tipo.
Sempre in tema di relazioni tra lingua inglese e lingue locali asiatiche, ecco l’annuncio della long list del Man Asian Literary Prize di Hong Kong. Il premio era nato in origine per favorire l’accesso al mercato globale di opere scritte in cinese, indonesiano, coreano, malese o hindi e tamil (infatti concorrevano opera non ancora pubblicate in inglese, ma per le quali fosse disponibile una traduzione in inglese che veniva commissionata appositamente dalle case editrici o dagli autori stessi).
Ora partecipano opere già pubblicate, con il risultato sì di innalzare il livello dei romanzi che concorrono, ma al contrario l’effetto di prensentare romanzi che già sono stati pubblicati o lo saranno a breve in italiano. Murakami, Gosh, Shin Kiung-sook e tanti altri. Insomma meno interessante per chi fa scouting, e forse anche fuori tempo massimo per qualche edizione europea.
Il Singapore Writers Festival diventa a partire da questa edizione annuale: vedremo che direzione saprà prendere nel 2012. Io spero che riesca a guadagnarsi, magari anche per la posizione geografica, un ruolo di crocevia asiatico. Certo però, con traduzione simultanea dell’inglese in cinese e del cinese in inglese.


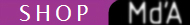


 Due weekend, e in mezzo un mercoledì festivo (
Due weekend, e in mezzo un mercoledì festivo ( Da un anno cerco di scrivere un post su
Da un anno cerco di scrivere un post su  Dedito, mi spiega lui, a “costruire modelli di aggiustamento dei default”. Gli ho chiesto: sarai mica uno di quelli che han combinato il megacrac? Dice no, semmai i miei modelli servirebbero a rientrare. Ma io sono solo un matematico, di soldi non ne so nulla. Dunque finanziario, matematico, poeta, di cognome fa Toh e Hsien Min di nome.
Dedito, mi spiega lui, a “costruire modelli di aggiustamento dei default”. Gli ho chiesto: sarai mica uno di quelli che han combinato il megacrac? Dice no, semmai i miei modelli servirebbero a rientrare. Ma io sono solo un matematico, di soldi non ne so nulla. Dunque finanziario, matematico, poeta, di cognome fa Toh e Hsien Min di nome.
 A una anno di distanza, una verifica dei cambiamenti in atto a
A una anno di distanza, una verifica dei cambiamenti in atto a  È un piccolo paese,
È un piccolo paese,  L’
L’ Amruta Patil da qualche mese è tornata a Goa, dove è nata e dove ha passato gli anni della primissima infanzia. Aveva bisogno di concentrazione per finire la sua nuova graphic novel,
Amruta Patil da qualche mese è tornata a Goa, dove è nata e dove ha passato gli anni della primissima infanzia. Aveva bisogno di concentrazione per finire la sua nuova graphic novel, 

