 La presentazione a Singapore del suo romanzo era in cinese, ma a cena Pway Ngon mi parla in inglese. Una lingua imperfetta, ma sufficiente per raccontarmi di questo suo ultimo romanzo, Art Studio appunto.
La presentazione a Singapore del suo romanzo era in cinese, ma a cena Pway Ngon mi parla in inglese. Una lingua imperfetta, ma sufficiente per raccontarmi di questo suo ultimo romanzo, Art Studio appunto.
C’è molta autobiografia. Ci sono le vite di un gruppo di artisti, seguiti dalla loro giovinezza (gli anni Sessanta) ai giorni nostri. Artisti, ma anche scrittori e giornalisti che Pway Ngon ha visto passare per trent’anni dalla sua libreria, piccola ma prestigiosa: la Grassroots Book Room.
Una libreria che ancora oggi combatte per la sopravvivenza, dentro a un mall (cioè a un edificio a più piani dove sui corridoi e sulle balconate si affacciano negozi di ogni tipo), oramai troppo vecchio: costruito negli anni Settanta, appunto, non in grado di competere con le nuove e magniloquenti architetture contemporanee, con l’esibizione del lusso.
Ma la Grassroots Book Room ha ancora un nome importante, il mall in questione è proprio di fronte alla National Library. Pway Ngon, stufo di passarci la giornata dopo più di trent’anni, la sta affidando in gestione, e finalmente si prenderà più tempo per scrivere.
Scrivere: di sé stesso, direi. È uno di quegli scrittori che della propria esistenza fanno il fulcro della narrazione. Pway Ngon, credo, ha bisogno di farci sapere quel che ha visto attorno a sé, e sa farlo senza indulgere in narcisismi esasperati anche quando si tratta di menzionare i suoi anni di galera, la miseria conseguente a questi, la difficoltà di affermarsi come scrittore.
Quando Pway Ngon mi racconta dei suoi anni giovanili, racconta raramente di sé: dice io, ma solo per introdurmi a ciò che lo circondava.
Qui a cena gli argomenti sono vari. Mi racconta Chennai, in India, dove lui è andato a stare per qualche settimana, per capire l’ambiente di provenienza di uno dei suoi personaggi, indiano di origine. Mi parla di un pittore, e io non riesco a distinguere il personaggio del romanzo dalla persona reale, l’amico che lo ha accompagnato per molti anni.
E poi, inevitabilmente, si torna a parlare della lingua, il cinese in cui scrive. Qui, di nuovo, la questione si fa complessa. Il cinese si basa sugli ideogrammi, ciascuno dei quali è foneticamente una sillaba, ma ha comunque un significato autonomo.
In sostanza: quando un cinese scrive o legge è come se avesse due piani di lettura, ogni parola ne contiene in sé altre due o tre. Quando scrive, invece di cercare una musica, un suono per le proprie parole, cerca una successione di immagini attinenti alla narrazione. Per questo la letteratura cinese è di così difficile traduzione nelle nostre lingue.
Ma da Pway Ngon scopro qualcosa di nuovo. Perché la domanda è: scrivendo al computer, cosa succede? Che tastiera usi? Come fai ad avere a disposizione centinaia di ideogrammi? E la risposta è sorprendente: io scrivo con il vostro alfabeto. Pway Ngon, e così tutti coloro che scrivono direttamente al computer, traslittera automaticamente. Pensa una parola pronunciandola dentro di sé, la scrive su una tastiera qwerty come tutti noi, e un programma fa comparire sulla pagina l’ideogramma corrispondente.
A me sembra un processo faticoso, pazzesco: lui mi dice, mentre scrivo è come se cantassi. Mentre rileggo, come se guardassi un mio dipinto.

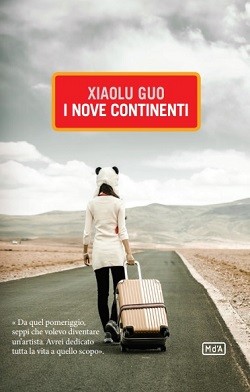
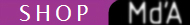




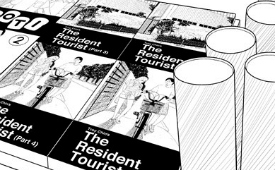 Trovare il modo giusto per descrivere questo artista non è semplice. Vorrei evitare di andare per frasi fatte.
Trovare il modo giusto per descrivere questo artista non è semplice. Vorrei evitare di andare per frasi fatte. E sicuramente una voglia di futuro: lo confessa il personaggio Troy Chin alla sua Mint, in cima al Flyer di Singapore, la ruota panoramica più alta del mondo, dove lei gli dice, papale papale: tu non hai un lavoro, Troy, che futuro vuoi costruire con me? Perché così è: quando Troy tornò a Singapore non aveva in mente altro se non raccontare quel che ritrovava e quel che avrebbe voluto ritrovare.
E sicuramente una voglia di futuro: lo confessa il personaggio Troy Chin alla sua Mint, in cima al Flyer di Singapore, la ruota panoramica più alta del mondo, dove lei gli dice, papale papale: tu non hai un lavoro, Troy, che futuro vuoi costruire con me? Perché così è: quando Troy tornò a Singapore non aveva in mente altro se non raccontare quel che ritrovava e quel che avrebbe voluto ritrovare. L’editore più socievole e simpatico che abbia mai incontrato in Asia si chiama Chu An Min, ha fondato una casa editrice indipendente col nome di INK, e io non sono mai riuscito a parlargli.
L’editore più socievole e simpatico che abbia mai incontrato in Asia si chiama Chu An Min, ha fondato una casa editrice indipendente col nome di INK, e io non sono mai riuscito a parlargli. C’è una scala mobile a
C’è una scala mobile a  Metropoli d’Asia e’ entrata a far parte di un pool di editori asiatici che ha recentemente assegnato un premio a quello che viene considerato il miglior giallo dell’Asia orientale.
Metropoli d’Asia e’ entrata a far parte di un pool di editori asiatici che ha recentemente assegnato un premio a quello che viene considerato il miglior giallo dell’Asia orientale. Lo incontrerò a Hong Kong nei prossimi giorni, ne parleremo. Intanto possiamo dire che il titolo provvisorio del giallo e’ “Dimenticare. Polizia criminale”. Nella foto ecco Soji Shimada con il nostro Ho Kei, a destra.
Lo incontrerò a Hong Kong nei prossimi giorni, ne parleremo. Intanto possiamo dire che il titolo provvisorio del giallo e’ “Dimenticare. Polizia criminale”. Nella foto ecco Soji Shimada con il nostro Ho Kei, a destra. Ho enfaticamente intitolato un recente post
Ho enfaticamente intitolato un recente post  Una delle architetture piu belle della scintillante
Una delle architetture piu belle della scintillante  Abbiamo già parlato di
Abbiamo già parlato di 

