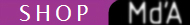Tornare a Bombay dopo quasi tre anni è buona occasione di confronti. Tutti mi chiedono: hai visto com’è cambiata? Io abbozzo, perché non vedo quasi niente.
Tornare a Bombay dopo quasi tre anni è buona occasione di confronti. Tutti mi chiedono: hai visto com’è cambiata? Io abbozzo, perché non vedo quasi niente.
Vengo da Singapore, da Hong Kong, da Kuala Lumpur, e non posso stupirmi più che tanto individuando – lontane da dove passo io – sagome di nuovi grattacieli all’orizzonte in certe zone centrali della città, Dadar, Lower Parel, Worli.
Mi dicono che i palazzi vengano su alti e stretti (o schietti?…) lasciando però la vecchia Bombay a prosperare ai loro piedi.
Come a dire che chi si può permettere un micro appartamento al trentaquattresimo piano in superlusso, una volta uscito dal portone ritrova sporcizia, gente che dorme per strada, baracchini che vendono ogni cosa, spazzatura e il consueto e cordiale odore misto di fognature, spezie e incenso che è sempre stata l’India (non dimenticherò mai il giorno del mio primo atterraggio nella città, ancora in aeroporto davanti al nastro bagagli un manager olandese incazzato che mi diceva: India stinks. L’India puzza: è vero, quell’odore lo senti appena passato il controllo passaporti. A me piace, guarda un po’).
Del resto, appunto, questa è la differenza tra le tante metropoli d’Asia e le grandi città indiane: una democrazia sostanziale, che impedisce alla classe media tronfia e imperante di liberarsi dei propri servitori che invece restano saldamente aggrappati alle sue caviglie. Costruendo questa organizzazione sociale profondamente interconnessa, dove gli intoccabili e i padroni delle ferriere convivono gomito a gomito e nessun ricco può dimenticare cosa c’è fuori dal recinto, perché il recinto non è stato costruito.
Le grandi città cinesi, Pechino, Shanghai, sono invece organizzate per gradi di separazione: come vigesse un’apartheid di censo, che lascia la povertà a venti chilometri dal centro scintillante, un’apartheid che separa i due mondi in modo netto e anestetizza le differenze sociali, creando zone franche, asettiche, emancipate dalla confusione e dal conflitto.
È l’India, questa, corrotta e ingovernabile, che cresce senza infrastrutture perché il Centro (lo chiamano così, il governo nazionale: molto Orwelliano, sì) è immobile e ci mette sette anni a costruire il nuovo ponte che dalla Highway (si fa per dire) dell’aeroporto, porta in un balzo alle soglie di Bombay South con un risparmio di mezzora buona sul traffico intasato.
E tutti a dire: e ci vorranno altri sette anni perché il ponte arrivi fino a Marine Drive, qui non siamo mica in Cina, qui per costruire qualcosa ci vogliono generazioni. E io faccio notare che il ponte lo ho attraversato quattro volte in taxi: c’è un casello, dove a mano si scambiano cinquanta rupie con una ricevutina, e a questo casello non ho mai trovato code perché cinquanta rupie per attraversare Bombay non se le può permettere nessuno qui: il ponte separa, per la prima volta, i due mondi.
Il famoso attore Bollywoodiano che uscendo dal pesante cancello di metallo della sua villa a Bandra si trova di fronte le baracche maleodoranti, e le vede dalla vetrata del salotto di casa sua, le sente nel naso, nelle ossa. Qui, sul ponte, è isolato. E percorre la baia osservando lontane, appunto, le nuove torri di Lower Parel, sognando una Singapore o una Hong Kong che qui non c’è e non ci sarà mai.
Io, ben protetto e isolato all’origine (Milano, Italy, Europe, In The West), resto a Bombay South ben protetto dentro a un appartamento signorile. Ne esco per godermi questo pezzo della città che ricorda un’altra fantascienza rispetto a Singapore (non Ballard) o Hong Kong (non le coreografie di Blade Runner): quella di certo fumetto nostro fine settanta primi ottanta (Bilal?), il degrado, il fatiscente del barocco aggredito dalle piante rampicanti che si infilano in ogni crepa di palazzi maestosi, arcate sovrastate da leoni assirobabilonesi, o più gentili architetture misto legno di bovindi, balconate, con pezzi interi di muro sradicati dalle radici di mandorli indiani improbabilmente affacciati a un quarto piano (altro che giardini verticali archistar di Singapore!).
E i palazzi vittoriani ed elisabettiani lasciati dai Brits, circondati di giardini abbandonati a sé stessi, al loro squallore ma alla loro frescura e silenzio, perché appena fuori il marasma è la regola, i corpi esalano, le esistenze stentate dei chaiwalla che portano il tè negli uffici delle società di marketing contaminano i creative managers, e si mangia con le mani, sporcandosi le dita di condimenti risultato di mille incroci, di ventidue lingue ufficiali riconosciute dal Centro, di culture e religioni e sette lontane tra di loro fino a tremila chilometri, dall’Himalaya all’equatore, dal Sud-est asiatico all’universo islamico.
Foto: ShashiBellamKonda